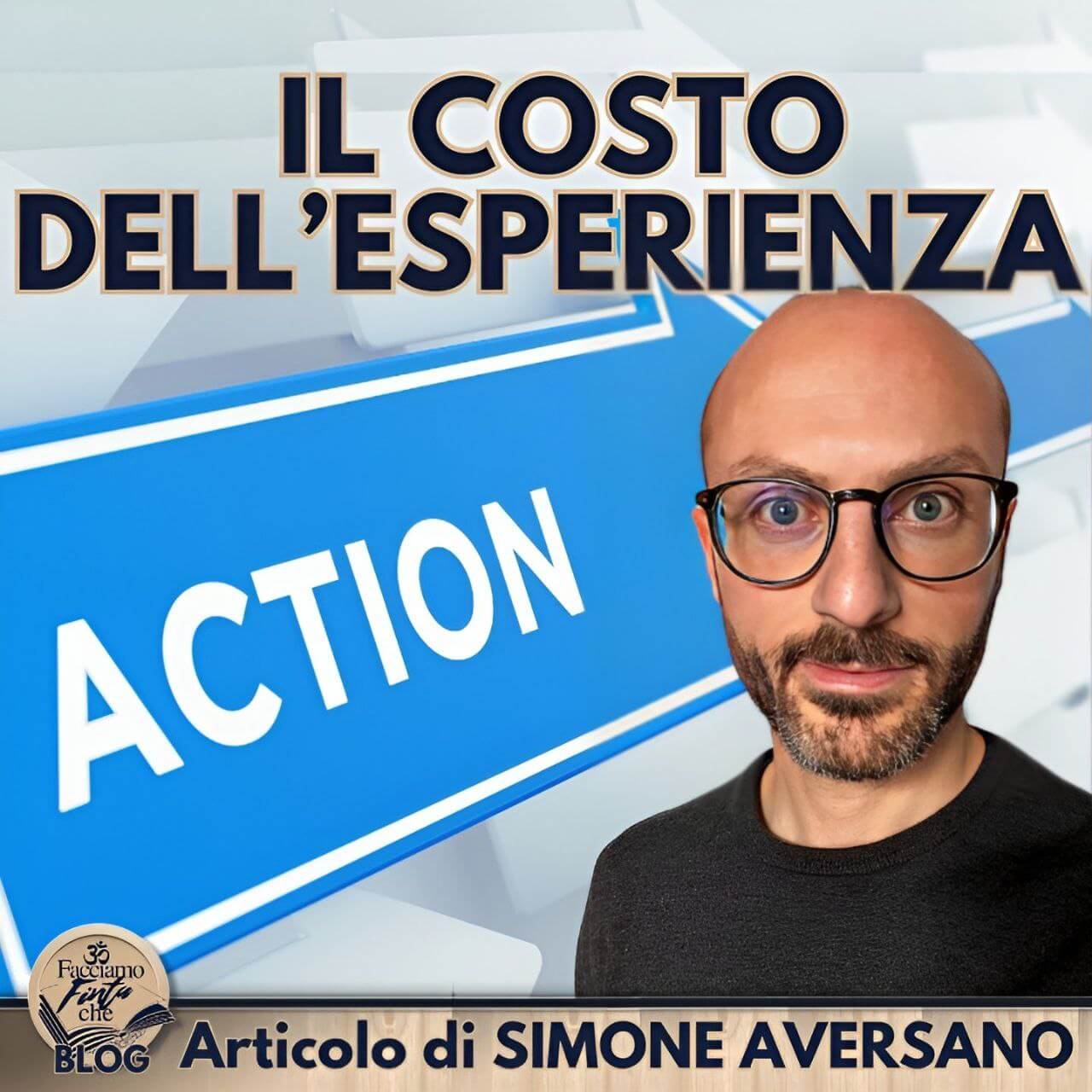Il fare è nemico dell’essere? Probabilmente no, prevalentemente no. Ma il fare distoglie e distrae dall’essere. Soprattutto, il fare distrae dalla comprensione di sé, che è la versione più profonda dell’essere. Essere non è automaticamente essere consapevole, non senza un percorso di acquisizione di consapevolezza; ma essere consapevole è essere nella sua massima espressione.
Per essere dobbiamo fare? A livello primordiale sì, nella misura in cui senza fare non si esiste perché ci si sottrae all’evoluzione, al tutto che vibra e perciò si materializza e appare, divenendo percepibile. Ma se il fare disturba il raggiungimento di una più piena consapevolezza di sé, come si risolve questo enigma? Come si sbroglia questa matassa?
Bisogna fare un passo indietro e tornare sul concetto di fare.
C’è un fare attivo e un fare passivo. Il fare passivo è quello che si subisce, la routine quotidiana, la frenesia, il rispetto delle etichette e dell’identità che negano la libertà all’individuo. Fare passivo è essere ciò che si è secondo la società, è recitare la propria parte e interpretare il proprio ruolo; anzi, il ruolo e la parte che ci sono stati affibbiati da qualcun altro e che noi abbiamo accettato. Perché non esiste nulla al di fuori della nostra volontà, concetto sul quale abbiamo intenzione di tornare più volte.
Quindi, il fare passivo è l’individuo che subisce l’apparenza della propria esistenza nel lavoro, nella famiglia, nella società, anche con se stesso. Se ci guardiamo allo specchio (attività che dovremmo compiere più di frequente, ma soprattutto con più consapevolezza), sbadatamente e distrattamente confermiamo a noi stessi che siamo quello che abbiamo accettato di essere secondo le etichette degli altri: siamo quello che non siamo e lo dichiariamo razionalmente a noi stessi ogni giorno, reiterando l’interpretazione drammatica di una vita che non dominiamo ma dalla quale veniamo dominati. È il grande inganno dell’identità, per superare il quale, come abbiamo detto, serve un percorso di acquisizione di consapevolezza che passa anche attraverso il punto in cui ci è chiaro che siamo quello che non siamo.
Il fare attivo dipende dalla volontà, è esecuzione dell’atto di volontà; ma la volontà non è senza la consapevolezza, perché per dire io voglio devo innanzitutto dire io, e poi io sono, e quindi io chi sono?
Ma chi giunge in quel punto, lasciandosi alle spalle la basilare consapevolezza minima di sé, riesce a dire io voglio e di conseguenza fa quello che vuole.
Provate a dire a chi è ancora vittima della propria razionalità e del proprio fare passivo che tutti dovrebbero fare ciò che vogliono: rischiate di essere allontanati o per lo meno zittiti in malo modo, per ragioni che pure proveremo ad approfondire in seguito (l’insofferenza del singolo verso ciò che fanno gli altri, quando si contrappone a ciò che egli fa). Ma in verità se tutti facessimo ciò che veramente e profondamente vogliamo, dopo aver compiuto quel percorso coscienziale che ci porta a comprendere chi siamo e di conseguenza cosa vogliamo, saremmo istantaneamente tutti liberi e felici, e non occorrerebbe alcuna barriera sociale, legale, politica, culturale o di altro genere perché ognuno semplicemente sarebbe nel senso di essere, e dunque nel senso del fare attivo.
Io sono, quindi io voglio, quindi io faccio.
Abbiamo sciolto i passaggi fondamentali per arrivare a discutere di un’altra questione: per comprendere bisogna prima aver fatto o per fare bisogna prima aver compreso?
È il cane che si morde la coda, o se preferite l’Uroboro, l’eterno ritorno dell’uguale, banalmente l’uovo e la gallina. Quale viene prima? Chi genera cosa e chi viene generato?
Vedremo nel prosieguo del percorso che nessuno genera e nessuno viene generato, non univocamente almeno, perché ogni cosa genera nel momento in cui viene generata e viene generata nel momento in cui genera.
Ma nella dualità pratica, quella in cui ci sembra di dover scegliere quale porta aprire o quale strada imboccare, o vale la regola secondo cui prima si fa e poi si comprende o la regola secondo cui prima si comprende e poi si fa.
Se io per comprendere devo fare, il mio fare mi porterà a comprendere in maniera induttiva, partendo dalla mia esperienza particolare per astrarre il caso singolo a ipotesi generale; se io per fare devo prima aver compreso, il mio fare sarà esecuzione pratica di ciò che in teoria, e secondo il metodo deduttivo, ritengo di aver compreso.
Nel primo caso, con il primo approccio, mi occorrerà fare una miriade di cose per comprenderne altrettante? Nel secondo caso, seguendo il secondo approccio, rischio di non arrivare a fare un bel niente per il troppo tempo, spazio ed energia destinati alla comprensione non pratica?
Ecco che probabilmente i due approcci devono necessariamente compenetrarsi, sovrapporsi e convivere, essere utilizzati insieme quantomeno alternativamente, a seconda dei casi, del soggetto e del contesto.
Esemplificando: per capire come si attraversa la strada devo aver attraversato la strada, ma per attraversare la strada devo aver compreso come si attraversa la strada.
Su un altro piano, la comprensione che precede il fare attivo potrebbe condurre a contaminazioni dell’essere e condizionamenti del fare, nella misura in cui nessuno può insegnare niente a nessun altro perché la comprensione può essere soltanto un passaggio coscienziale individuale, portato avanti con le sole proprie forze. E torniamo al punto dell’atto di volontà: io comprendo chi sono solo dopo che ho voluto comprenderlo, quindi per l’io sono che conduce all’io voglio occorre che almeno un io voglio abbia preceduto l’io sono.
Insomma, apparentemente non se ne esce.
O forse è proprio questa la strada: un primo fare attivo, un tentativo, un buttarsi rischiando nell’inconsapevolezza per uscire da essa, acquisendo consapevolezza dell’essere attraverso il fare e potendo quindi continuare ad essere nel fare attivo che deriva dalla volontà.
Comunque sia, comunque la si pensi, comunque si intenda procedere, essere vuol dire fare esperienza. Esperienza di sé quindi degli altri, che riflettono le profonde ragioni e regioni dell’essere.
Ma l’esperienza ha un costo, non solo un valore. Il costo dell’esperienza è fatto di tutto ciò che residua lungo il percorso: i così detti errori, le strade “sbagliate”. Questi sono elementi evolutivi perché spiegano e insegnano, semplicemente mostrando per sottrazione quale doveva e dovrà essere la via. In questo senso non esiste bene e male, ma solo l’esperienza. Tutto serve, tutto è utile, tutto produce effetti, tutto genera mentre viene generato. La scelta è di per sé evolutiva, costruttiva, vitale, esperienziale, coscienziale.
In altre parole, il vero costo dell’esperienza è il non-fare. Non fare l’esperienza è il vero peso, il vero limite, il vero ostacolo all’acquisizione di consapevolezza. Il non fare nasce a volte dalla paura, che a sua volta affonda le radici nell’ignoranza come inconsapevolezza, nel non essere nel senso di non aver ancora compreso io chi sono.
Se ci chiediamo quanto ci costerà fare un’esperienza, la contro-domanda da porsi è quanto ci costerà, in termini di essere, non farla.
di Simone Aversano
Questo è il secondo articolo di una serie ispirata al percorso “Conosci te stesso”, il primo articolo è disponibile cliccando sul seguente link: “Siamo quello che non siamo“.
Per approfondire le tematiche dell’articolo, ecco la playlist alla terza stagione del format “Conosci te stesso”, appuntamento settimanale con il dr. Pierluigi Mulattieri andato in onda sul canale youtube MesbetTV: