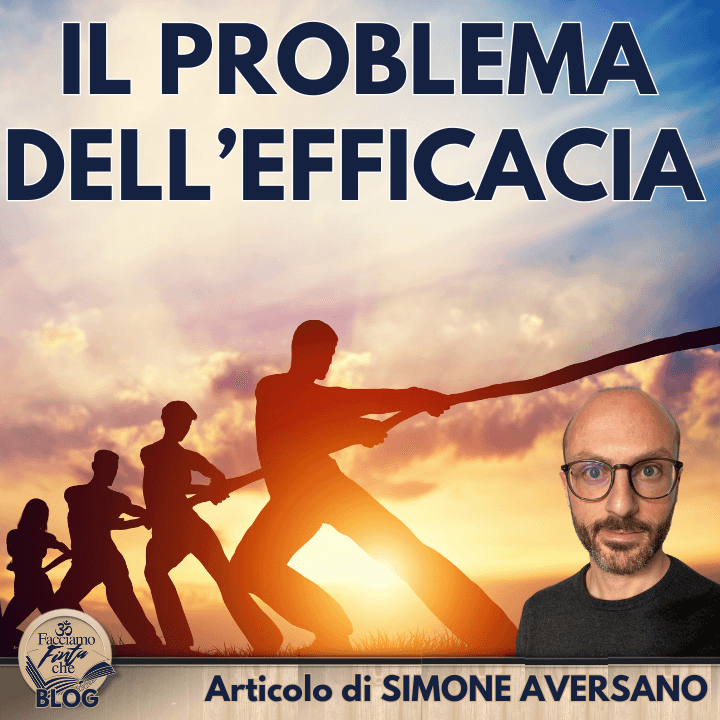Lo specchio ci restituisce l’immagine di noi stessi. Nelle cose che ci circondano vediamo e percepiamo il benessere e il malessere interiore, spesso senza capire che non esiste vera separazione tra dentro e fuori, tra io e l’altro. Io sono l’altro e io sono nello specchio, in tutto quello che si manifesta fuori di me, comprese tutte le cose che non accetto, non comprendo, non voglio e mai ammetterei essere parte di me, anzi soprattutto queste.
Per questo combattiamo la realtà e la quotidianità, ci contrapponiamo agli avvenimenti e alle persone, esprimiamo opinioni tramite parole e gesti, scelte di azione e scelte di espressione, come il modo di vestirsi o i luoghi che frequentiamo. In un certo senso combattiamo per affermare ciò che vogliamo essere, ma molte volte non sappiamo ancora bene né chi siamo né di conseguenza che cosa vogliamo davvero. Infatti nelle nostre espressioni c’è tantissima ricerca di etichette e stendardi, sotto i quali andare a collocarci per semplificare la definizione di ciò che siamo: io sono un elettore di quel partito politico, un tifoso di quella squadra, un membro di quel gruppo di conoscenti, un partecipante di quelle serate e quegli eventi, un dipendente di quell’azienda, un rispettabile individuo con quel preciso stile di vita che richiama l’appartenenza ad un gruppo sociale e culturale, che psicologicamente mette in salvo da altre etichette ritenute sconvenienti. In questo senso, fare ciò che non si ha alcuna voglia di fare sarebbe un ottimo modo per espandersi nella propria consapevolezza di se stessi, un passaggio evolutivo di illuminazione delle ombre e riduzione di limiti mentali e paure, tra cui quella onnipresente di venire esclusi e rimanere soli. Paura della solitudine che poi non ha alcun senso, dal momento che io sono incessantemente e io sono l’altro, quindi nessuno è mai solo perché ogni cosa è io; il problema casomai sta nella percezione di solitudine, che descrive istantaneamente la scarsa consapevolezza di se stessi, così che l’io viene mangiato dall’inconscio e dalle sue ombre.
Nella battaglia continua per l’affermazione di ciò che riteniamo di essere e vogliamo essere, si pone il problema fondamentale dell’efficacia.
Prendiamo due coniugi che litigano frequentemente per le stesse situazioni, che possono essere le più disparate e le più ridicole, nel senso di insignificanti se paragonate alla globalità del percorso di acquisizione di consapevolezza (quanto fa ridere pensare di innervosirsi e stare male per una macchia su una camicia o per un’insalata condita male?). L’uno e l’altra sono in conflitto per cercare di cambiare determinate situazioni, e in definitiva per cambiare l’altro nei suoi comportamenti che l’uno non riesce a sopportare. Ma davvero c’è la volontà di migliorare il rapporto, cioè di stare meglio? Davvero nei litigi, nei contrasti, nelle incomprensioni e in tutte le espressioni di quella conflittualità si afferma la volontà di superare quest’ultima per aumentare il grado di amore vissuto e di benessere insieme?
Allo stesso modo possiamo esemplificare parlando di genitori e figli, di fidanzati, di amici, di persone in rapporto subalterno come insegnante e alunno o lavoratore gerarchicamente superiore ad un altro lavoratore. Situazioni di vita quotidiana, per molti la vita vera al di là delle chiacchiere. E potremmo spingerci oltre, sfociando nella collettività, come il rapporto tra cittadino e stato, o tra gruppo di persone e contesto superiore (un’azienda multinazionale, un ente locale, un’istituzione). Nelle concrete espressioni della conflittualità che persiste tra queste entità contrapposte, quanto è vera e sincera la volontà di vincere, di avere ragione, di cambiare le cose, di ottenere il successo sull’altro?
Facciamo un passo indietro. Vincere cosa significa? Possiamo dire che significa affermare le proprie ragioni ottenendo soddisfazione, cioè una posizione di vantaggio rispetto all’altro, seppur momentanea. Così, avere ragione significa poter fare secondo la propria idea senza che l’altro possa obiettare alcunché o in qualche modo impedirci di fare come vogliamo. Cambiare le cose va visto sempre nel senso di avere ragione e vincere, cioè ottenere il successo sull’altro. In sostanza, sono tutte espressioni di una conquista, di una modifica della percezione individuale della realtà esterna in modo che corrisponda meglio al disegno della situazione che abbiamo scelto e voluto (o che il soggetto aveva detto a se stesso di volere, più o meno sinceramente).
Ma se io sono l’altro, che senso ha vincere e avere ragione sull’altro?
E ancor prima: se io non sono pienamente consapevole di chi sono, tanto da non aver capito che io sono l’altro, come posso sapere cosa voglio al punto da cercare di affermarlo nella battaglia per il successo?
Queste domande non necessitano di risposta, perché la risposta è indifferente. Caso per caso ve ne sarà una e di conseguenza si determinerà un valore della situazione in termini di acquisizione di consapevolezza. Ma non fa differenza rispetto al punto fondamentale del discorso: il problema dell’efficacia.
In altre parole, facciamo finta che l’individuo sia davvero consapevole di chi è e di cosa vuole nel momento in cui combatte per affermare questa sua volontà di cambiare le cose, avere ragione, vincere e conquistare il successo: in che modo pensa di farlo?
Torniamo per un attimo ai due coniugi: il litigio continuo per una medesima situazione che si verifica più o meno identica ciclicamente è già la risposta al quesito. Il ripresentarsi dello stesso problema significa implicitamente due cose: che entrambi lo affrontano sempre nella stessa maniera e che, di conseguenza, nessuno dei due vuole veramente risolverlo. Io sono l’altro anche nel senso che io sono i miei bisogni, compresi quelli che mi fanno apparire davanti agli occhi quei problemi che combatto quotidianamente. È un discorso legato alla contrapposizione e alla resistenza, come nel tiro alla fune. Ma nel tiro alla fune, non vince chi tira più forte: vince chi molla la fune. La soluzione è nell’uscita dalla dualità su cui si fonda la contrapposizione, o meglio nell’acquisizione di consapevolezza che conduce a comprendere che fintantoché io litigo con una persona per avere ragione non posso mai vincere, e infatti realmente e profondamente non voglio nemmeno farlo. Se io ho bisogno di quella contrapposizione per percepire il senso dell’affermazione della mia opinione, come posso superare evolutivamente quella situazione così da perdere l’occasione per continuare a combattere? Mi sentirei sconfitto e debole, perché non più impegnato nella battaglia e dunque impossibilitato ad avere ragione, successo e vittoria. Ecco allora che il litigio continuo spiega se stesso come bisogno involutivo dal quale non si vuole mai uscire, situazione che non si vuole mai cambiare, perché è proprio nel litigio che si riesce ad avere ragione sull’altro affermando razionalmente le proprie argomentazioni. L’individuo spesso si sente vivo quando può dire come la pensa, e su questo ci hanno fondato business alquanto redditizi con quegli strumenti antisociali e antiumani che sono i social network (c’avete mai fatto caso che su qualcuno di questi campeggia costantemente in primissimo piano la domanda “a cosa stai pensando?”). E allora tra il rischio di essere sconfitto e la certezza (presunta) di morire, l’individuo reitera costantemente la scelta di combattere, di continuare a tirare la fune dalla sua parte, pur sapendo (perché le cose sono andate sempre così finora) che in questo modo non troverà mai piena soddisfazione, benessere, amore e miglioramento delle proprie condizioni di vita.
Nei rapporti tra gruppi di singoli ed entità superiori, siamo veramente sicuri che le battaglie per affermare i propri diritti siano volte alla definitiva affermazione di quei diritti? Se io combatto per la mia libertà, intanto non ho compreso che io sono sempre libero e che se la mia libertà devo andare a reclamarla allora non è libertà, ma soprattutto l’effetto psicologico del successo può essere un deterrente rispetto alla piena volontà di raggiungerlo, perché in quell’istante posso smettere di combattere ma automaticamente mi sento più vuoto, meno vivo e meno soddisfatto. Tutto dipende, insomma, dal valore soggettivo della battaglia: se in essa io percepisco già il senso di ciò che voglio ottenere, cessata la battaglia io ho perso anche se ho vinto, perché ho ottenuto quello che formalmente volevo ottenere ma in quel medesimo istante l’ho perso perché non posso continuare a combattere.
In questo senso si spiegano le conflittualità che sembrano inseguire l’individuo come la nuvola di Fantozzi: gli stessi problemi che si ripresentano anche cambiando lavoro, amici, colleghi, partner, residenza, o passando dalla vita lavorativa alla vacanza. Per quale strana ragione, dopo aver cambiato ogni altro ingrediente meno che se stessi, il piatto ha lo stesso sapore disgustoso di prima? Anche attraverso questo capiamo che io sono l’altro.
I problemi che ci trasciniamo in tutte le situazioni come un bagaglio a mano raccontano chi siamo e cosa vogliamo veramente, e cioè non la risoluzione ma il mantenimento del problema. Noi siamo il problema perché del problema ci alimentiamo, grazie ad esso viviamo nella costante ricerca dell’affermazione delle proprie ragioni, dei propri diritti e della propria libertà. Ecco allora che molto spesso chi vuole qualcosa non la vuole veramente, anche se evita di fare proclami preventivi e si limita ad agire e a far parlare i fatti.
Tutto, in definitiva, dipende dal bisogno che si ha. E il bisogno dipende dall’essere, perché io sono ciò di cui ho bisogno. Nel percorso di acquisizione di consapevolezza, luce e ombra si contrappongono e si bilanciano ma l’una non può esistere senza l’altra. Questa esistenza vicendevole e condizionata è forse la matrice dell’eterna lotta con noi stessi, nell’illusione di combattere qualcosa di esteriore, qualcosa di altro, senza mai poter e voler vincere veramente. In fondo, vincere è un po’ come morire, come aver concluso l’esistenza. Anche per questo in realtà si mente a se stessi dichiarando che si vuole vincere, avere ragione, avere successo e cambiare le cose. “E dopo che faccio?” sembra chiedersi una parte della propria coscienza.
In tutto ciò sta il problema dell’efficacia, cioè della modalità migliore per raggiungere veramente l’obiettivo dichiarato. Ed ecco che la vera battaglia è sempre contro se stessi, sia perché l’altro sono io sia perché concretamente lo scontro costante è tra il proprio essere e le bugie illusorie che l’individuo continua a raccontare a se stesso per non morire.
di Simone Aversano
- Questo è il quinto articolo di una serie ispirata al percorso “Conosci te stesso”, i primi articoli sono disponibili cliccando sui seguente link:
1 – “Siamo quello che non siamo“; 2 – “Il costo dell’esperienza“; 3 – “L’altruismo è il peggior egoismo“; 4 – “Io sono dentro lo specchio“
- Per approfondire le tematiche dell’articolo, ecco la playlist alla terza stagione del format “Conosci te stesso”, appuntamento settimanale con il dr. Pierluigi Mulattieri andato in onda sul canale youtube MesbetTV: